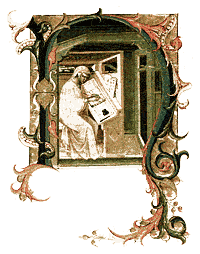interuniversitario di teoria e storia dei generi letterari dell'Università di Torino, 1997, numero 2, anno IV, pagine 87 - 92, Edizioni dell'Orso, Alessandria
Uno dei
tratti salienti che contraddistingue la scrittura di Dante attraversando
tutte le sue opere, ora in forma evidente ora sotto il sembiante di
una "teatralizzazione" qual è quella della
Commedia, è costituito dall'esercizio del commento. Si tratta di
una prassi scritturale "ascetica" nel senso etimologico del termine,
tipica dell'orizzonte culturale del Medioevo, il cui mondo ha guardato
a se stesso "come ad una appendice dei testi classici", secondo l'analisi
condotta da Giorgio Agamben sulla scia del concetto spengleriano di
"pseudomorfosi"[1].
La matrice storico-teologica che fonda la categoria del "commento" va
tuttavia rintracciata nella dimensione escatologica che caratterizza
il monoteismo delle religioni del Libro. L'interpretazione dei testi
sacri presuppone che la Verità rivelata all'uomo non sia oggettivabile
ed esplicitabile nel presente, se non come traccia di una Parusìa il
cui definitivo Avvento è promesso e differito alla fine dei tempi. L'ascesi
del commentatore riflette la sua condizione di viator, la nostra indigenza di creature che
dimorano nel frattempo pre-messianico. Un esilio ontologico sempre esposto
al rischio del dubbio e della disperazione di fronte all'asprezza della
Scrittura, al suo mutismo, di fronte alla precarietà di una parola che
manifesta la Verità sempre attraverso segni, indizi, vestigia. Ebraismo
cristianesimo ed islamismo risultano essere le differenti declinazioni
di una medesima tensione spirituale che procede dalla consapevolezza
di una netta divaricazione tra Rivelazione ed Apocalisse: lo spazio
intermedio tra questi due eventi delimita il dominio della glossa, della
chiosa, della meditazione teologica. E se la scrittura si attua come
Commento l'oggetto del commento, a sua volta, si dà come Scrittura.
Non c'è Summa che valga a saturare questo
spazio intermedio, non c'è parola che possa colmare, hic et nunc, l'abisso che separa
il Libro - traccia della Parola divina - dall'Apocalisse luminosa del
suo compimento escatologico. Nel mondo cristiano è la
prima lettera ai Corinzi di Paolo che individua le condizioni
di possibilità del discorso teologico:
nunc videmus per speculum in aenigmate, tunc autem
facie ad faciem (1 Corinzi 13,12). Il nunc della scrittura che commenta,
luogo d'esilio ed unica dimora possibile in via, è lo spazio del frattempo,
il già che attende il non-ancora dell'Eschaton. In questo itinerario in Deum i testi dei gentili possono
affiancare i libri sacri nella misura in cui quelli prefigurano l'annuncio
che i secondi ri-velano. L'equidistanza ontologica tra la dimensione
della scrittura in quanto tale e la Verità, vanifica ogni prospettivismo
storico, facendo sì che risulti irrilevante assegnare alle opere di
un Auctor una collocazione ben definita nel tempo. Il concetto medievale
di "tradizione", pertanto, determina una sorta di paradosso della simultaneità,
per cui tra parola dell'Auctor e glossa del commentatore non sussiste
alcuna sfasatura quando entrambe intenzionano l'atemporale Verità. In
questo consiste la vitalità del commentare, che nulla ha a che vedere
con l'invocazione autoritaria dell'ipse dixit. Se si tien fermo il
carattere disperatamente provvisorio della nostra parola di viatores non si potrà mai assumere,
idolatricamente, che la voce dell'Auctor sia riflesso immediato e "apocalittico"
del Verbo. Non si esce, qui ed ora, dalla dimensione della scrittura,
anche se questa può farsi tramite di una visione anticipante che prefigura
la visio facies ad faciem
oggetto della promessa escatologica. I testi citati e ricuciti dal commentatore
spesso parlano soltanto dopo esser stati strappati via dal loro contesto
originario storicamente determinato, per essere tradotti sul piano metastorico
della Tradizione. Buon commentatore si dimostra chi riesce a mantenere
il giusto equilibrio fra discrezione e nostalgia.
I testi danteschi costituiscono tutti una sorta di apoteosi del commento nella accezione che si è qui indicata. La dimensione speculativa del commento appare ancor più esaltata in testi come la Vita nova e il Convivio, là dove si assiste al ripiegamento della scrittura su se stessa entro l'opera dello stesso Auctor: il rapporto con la tradizione qui è mediato dallo sdoppiamento tra le canzoni e l'esposizione della loro "sentenza", tra senso letterale ed allegorico. Per giustificare un'operazione di questo tipo, Dante, nel primo libro del Convivio, costruisce una excusatio che può esser considerata retrospettivamente valida anche per la Vita nova. Non c'è alcun arrogante compiacimento autobiografico nel parlar di sé medesimo facendosi, ad un tempo, soggetto e oggetto del commentare, bensì una duplice necessità:
e questa necessitate mosse Boezio di sé medesimo a parlare, acciò che sotto pretesto di consolazione escusasse la perpetuale infamia del suo essilio, mostrando quello essere ingiusto, poi che altro escusatore non si levava. L'altra è quando, per ragionare di sé, grandissima utilitade ne segue altrui per via di dottrina; e questa ragione mosse Agustino ne le sue Confessioni a parlare di sé… (Convivio, I, ii, 13-15)
Il riferimento a Boezio e ad Agostino inscrive il "commento a se stesso" nella categoria dell'exemplum, ribadisce l'umiltà di colui che si propone come semplice ministro della tradizione, ma al tempo stesso innalza la propria opera al rango di Auctoritas a pieno titolo. L'esegesi delle canzoni, la lettura delle pagine scritte nel libro della memoria, lo sdoppiamento speculare dell'Auctor in soggetto dell'enunciazione e soggetto dell'enunciato trovano la loro ragion d'essere nel compito fondamentale assegnato al commento, che è quello di nobilitare le parole del nunc affinché in esse rifulga una scintilla della Sapienza eterna. Entelechia del commento è il diventare prolessi del tunc, anticipare in via la visione della Luce. Le due metafore del "pane" e della "navigazione" convergono in Dante a definire le coordinate della scrittura, investendo la questione del volgare e il problema del rapporto con la lingua latina. La novità del Convivio non consiste nel meccanismo speculare che dà luogo al commento come "commento a se stesso", ma nel fatto che l'elemento linguistico adottato non è più la lingua della scuola ma la lingua del popolo. La mossa successiva, che Dante effettuerà nel De vulgari eloquentia, consisterà nell'adozione del commento teologico come via per dimostrare la tesi della nobiltà del volgare, in un contesto che ripercorre le i topoi degli Auctores sul terreno della letteratura esameronale.
Harum quoque duarum nobilior est vulgaris (De vulgari eloquentia, I, i). "Quando una lingua è nobile?": si tratta di una questione che eccede i confini della retorica, dell'estetica o della stessa filosofia del linguaggio, e si pone sul piano di una antropologia teologica che nella sua latente matrice neoplatonica prelude al tema rinascimentale della dignità dell'uomo. Già nel Convivio Dante ha dato una definizione del linguaggio umano scrivendo che "…lo sermone…è ordinato a manifestare lo concetto umano" (Convivio, I, v, 12.. La funzione comunicativa del linguaggio è causa finale della parola, necessaria per l'uomo in quanto essere intermedio tra l'angelo e l'animale irrazionale. Gli angeli non comunicano attraverso la mediazione di segni sensibili, perché vedono direttamente i loro pensieri ciascuno nell'intelletto dell'altro, contemplandosi reciprocamente nell'universale Specchio della Divinità in quanto pure intelligenze senza corpo. Gli animali, corpi senza intelletto, comunicano all'interno della loro specie con actus et passiones che non rinviano a "significati", ma fungono da segnali o indici associati istintivamente a reazioni di un certo tipo. Soltanto l'uomo, essere razionale e corporeo, ha necessità di un linguaggio costituito da segni il cui duplice aspetto, sensibile e concettuale, si spiega considerando la sua finalità:
Hoc
equidem signum est ipsum subjectum nobile de quo loquimur: nam sensuale
quid est in quantum sonus est; rationale vero in quantum aliquid significare
videtur ad placitum.
(De vulgari eloquentia, I, iv).
La "nobiltà" dei segni è ciò che rende possibile la dimensione intersoggettiva e sociale della comunicazione, dimensione "politica" nel senso aristotelico sottinteso da Dante. E tuttavia questa sfera appare in tutta la sua "profanità" se viene commisurata al primo actus locutionis che l'autore ipotizza sia stato effettuato da Adamo, nonostante il libro della Genesi attesti che la prima a parlare, nell'Eden, sarebbe stata Eva. L'imposizione dei nomi agli animali, anteriore al dialogo tra Eva e il serpente, non costituisce un vero e proprio actus locutionis, se prendiamo questo termine secondo la definizione dantesca. [2] Adamo non parla agli animali quando assegna loro un nome, non comunica nulla, ma piuttosto assume la signoria su di loro. Allora, conclude Dante, è più razionale pensare che il primo a parlare sia stato l'uomo e non la donna, e non già con l'impositio nominum, atto che si colloca al di qua del linguaggio, bensì volgendosi a Dio per renderGli grazie del dono appena ricevuto. L'autentico actus locutionis che inaugura il linguaggio è quindi il nome di Dio proferito da Adamo (primus loquens, nobilissimum animal) in risposta gaudiosa all'appello del Padre che lo ha chiamato all'essere. (De vulgari eloquentia, I, iv) La tradizione riporta che il nome di Dio in ebraico è El, e la lingua delle origini parlata dal primo uomo è appunto quel nobilissimo volgare che rimase integro persino dopo la confusione delle lingue seguita al disastro della torre di Babele, concezione che Dante correggerà nel XXVI canto del Paradiso. Attraverso un commento alla Genesi che non ha precedenti nella letteratura esameronale, Dante individua una dimensione della nominazione anteriore all'impositio nominum: prima della parola che si impone sugli enti creati sancendo il dominio dell'uomo sulla natura e rendendo possibile la dimensione comunicativa del linguaggio, vi è la parola che ex-clama il Nome del Padre rispondendo al suo appello con la sollecitudine caratteristica della creatura fatta a sua immagine e somiglianza, e ancora incorrotta dal peccato. Il Nome primordiale non denota un ente creaturale finito e determinato, bensì invoca l'Essere che è sorgente luminosa del creato. "El" è il Nome dei nomi, anteriore allo spazio profano della referenza, una sorta di "punto" simplex in cui il linguaggio si contrae allo stesso modo per cui in Dio, Punto da cui depende il cielo e tutta l natura, si riassume tutto ciò che per l'universo si squaderna.[3] Il modello scolastico della impositio nominum viene così sostituito da una concezione del linguaggio che risale alla mistica francescana, e che risuona sovente nelle pagine di Bonaventura da Bagnoregio:
Ad quid enim data est intelligentia et lingua, nisi ut Deus laudetur et magnificetur?[4]
Qui causa finale del linguaggio non è più la comunicazione tra creature, ma la lode del Creatore magnificato per le sue opere ed invocato in una preghiera corale di ringraziamento, preghiera che è essa stessa lode, e non "venal prece". L'esclamazione gaudiosa di Adamo sembra costituire il prototipo dello stesso Pater noster. Nobilissima sarà allora quella parola che si fa scala verso l'Invisibile, sciogliendosi dal carico semantico che la incatena alle cose del mondo ed innalzando un canto a Gerusalemme, patria celeste e dimora promessa agli abitanti del frattempo. Sembra in tal modo che la scrittura, quando si permea del pathos della preghiera, si dissolva nel sensus anagogicus, quando cioè essa
Per le cose significate significa de le superne cose de l'etternal gloria. (Convivio, II, i, 6).
Più che un senso tra gli altri, quello anagogico, che Dante chiama anche "sovrasenso" costituisce una linea di fuga verso l'Invisibile e fuori dal regime stesso del Senso tout court, che presuppone un'assegnazione dei nomi alle cose. L'archetipo di tale scrittura è dato dai Salmi, i canti di lode in cui la kenosis dei segni è costantemente protesa ad inneggiare l'Ineffabile. È la stessa parola del frattempo ad esser segnata, radicalmente, da una matrice anagogica. Ma affinché tale matrice si dispieghi abbandonando il dominio della retorica che caratterizza gli imitatori dei modelli pagani, è necessario che l'Auctor, novello Adamo, risponda all'appello del Padre entro il linguaggio che gli è proprio. Il gaudium al quale egli ci chiama come commensali fa risuonare l'esclamazione primordiale, declinando il Nome originario nei due registri della poesia e della prosa, in maniera tale da renderli perfettamente sovrapponibili alle pratiche "ascetiche" del commento e della preghiera. La riflessione speculare che Dante-Auctor attua dalla Vita Nova fino alla Commedia, al di là delle differenze specifiche a livello programmatico e di poetica, appare allora inscindibile dalla funzione di intercessore che egli stesso rivendica in forme diverse. Intercessore è colui che fa, della scrittura del frattempo, un'ek-statica prolessi dell'Apocalisse, prefigurazione dell'Eschaton e rammemorazione del dono della parola. La coappartenenza di preghiera e riflessione teologica entro il comune orizzonte dell'ascesi scritturale rinvia direttamente al prologo dell'Itinerarium mentis in Deum:
Non enim dispositus est aliquo modo ad contemplationes divinas, quae ad mentales ducunt excessus, nisi cum Daniele sit vir desideriurum. Desideria autem in nobis inflammantur dupliciter, scilicet per clamorem orationis, quae rugire facit a gemitu cordis, et per fulgorem speculationis, qua mens ad radios lucis directissime et intensissime se convertit.[5]
Il nesso tra scrittura e desiderio in Dante costituisce l'elemento di saldatura tra le immagini del banchetto e della navigazione:
…drizzato l'artimone de la ragione e l'òra del mio desiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino e di salutevole porto e laudabile ne la fine de la mia cena. (Convivio II, i, 1).
In tal modo la stessa figura di Beatrice, oggetto del desiderio e specchio su cui si curva la riflessione teologica della terza cantica, diviene l'emblema del carattere anagogico della scrittura. Ed è soltanto con l'adozione della lingua volgare che il commento perviene all'entelechia che gli è propria: nei due registri della poesia e della prosa la rammemorazione del Libro è accompagnata costantemente dalla rievocazione del Dono primordiale e del primiloquium adamitico che gli corrisponde gaudiosamente. Nel rapporto che intercorre fra la creatura imago Dei e il Padre la memoria funge agostinianamente da elemento di congiunzione [6], fino a identificarsi ad litteram con la scrittura in quanto tale.
[1] GIORGIO AGAMBEN, Stanze: la parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino Einaudi, 1977: "Per un fenomeno che è stato impropriamente ma suggestivamente definito di "pseudomorfosi" la civiltà arabo-medievale ha guardato a se stessa come a una appendice o a una glossa dei testi classici...distinguere tra una conoscenza di prima e seconda mano per una cultura della pseudomorfosi e del commento com'è quella medievale, cosa poco sensata..."
[2] UMBERTO ECO, La ricerca della lingua perfetta
[3] Rispettivamente in : Paradiso, XXVIII, vv. 41-42; e ibidem, XXXIII, v. 87.
[4] BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Sermones de Sanctis angelis 630a.
[5]BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum, Prologus 3.
[6] Su questo punto cfr. MARIA CORTI, Percorsi dell'invenzione. Il linguaggio poetico e Dante, Torino, Einaudi, 1993, pp. 44 e segg.