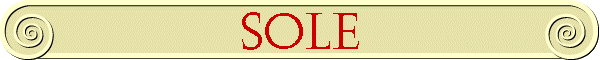|
NELLA
ANFUSO, CANTATRICE
di
Carlo Maria Cella
“…l’ordine col quale tutte le Arie divise in tre parti
vogliono essere cantate. Nella prima non chieggono, che ornamenti
semplici, gustosi, e pochi, affinché la composizione resti intatta.
Nella seconda comandano, che a quella purità ingegnosa un artificio
singolare si aggiunga, acciò chi se ne intende senta, che l’abilità di
chi canta è maggiore: Nel dir poi le Arie da capo, chi non varia
migliorando tutto quello, che cantò, non è grand’Uomo”.
(P.F. Tosi, Opinioni de’
Cantori Antichi e Moderni, 1723)

Quando apparve la raccolta di “Cantate e Mottetti”
di Vivaldi, per Arion, nel 1982, il precetto di Pier Francesco Tosi,
comandamento primo delle tavole della legge scolpite nelle “Opinioni
de’ Cantori Antichi e Moderni” - anno 1723 - si caricò di un valore
fino ad allora sconosciuto. E non per colpa del Tosi. Il parametro sul
quale misurare con senso quasi morale chi meritasse il termine di
Cantatrice o Cantatore della musica italiana più alta, dunque della
Musica tour court, mutò la soglia della sua tolleranza non perché
fossero cambiati la chiarezza e la forza del precetto, ma perché era
apparso un canto che aderiva come un guanto ai suoi modelli, e intorno,
automaticamente, mutava il paesaggio sonoro, i suoi esempi, i suoi
valori. Le “classifiche” che avevamo consciamente o
inconsapevolmente stilato, andavano riscritte. Ovvero abbassate di
grado. Che ciò non sia poi avvenuto come e quanto doveva,
è un altro capitolo della storia dell’interpretazione che va sotto molti
e vari titoli: Decadenza dell’Impero, Invasioni barbariche,
a scelta e senza pretese di originalità.
Quasi ci aggrediva il prodigio della cantata “Cessate,
omai cessate”: il suono rotondo e carico di “affetti” nel
Largo e sciolto; lo spiccato perlaceo, i trilli a note ben
staccate nell’Andante molto e nel Larghetto, sulle
sillabazioni tornite di “Dorilla”, “ingrata”,
“astringe” e “lagrimar”, e, infine, la progressione
inesorabile delle riprese, come ingiungeva il Tosi, il crescendo
delle fioriture dell’Allegro, nel rincorrersi e incalzarsi
di “orrido”, “albergo”, “ricetto”, “tormento”,
e ancora “Dorilla”, “spietata”, “ingrata”,
“morire”, “potrò”, nell’urtarsi e ordinarsi disciplinato del
circolo di erre e di ti, ben sopra e oltre il materiale
melodico, che rinvia a un’altra aria capolavoro del Prete Rosso,
“Sorge l’irato nembo”, tra le più belle dell’ “Orlando Furioso”.
Una voce di estensione e di virtuosismo
inauditi s’insinuava nella linea solista, contagiava lo strumentale
e lanciava Vivaldi alle stelle, faceva intendere a chiunque avesse anche
solo orecchio e “gusto”, che così “doveva essere”.
Nella Anfuso era la traduzione in atto dei comandamenti di Doni e
Tosi. Gli altri e le altre, passi falsi o incerti.
L’album vivaldiano, cui seguiranno i “Mottetti a canto
solo con istromenti” nel 1990 e l’Opera Omnia delle Cantate
per le edizioni Stilnovo nel 1991, è solo una delle stazioni
dell’opus Anfuso, da considerare ormai solo ed
esclusivamente nella sua interezza per valutare la portata
e le conseguenze del suo apporto alla musicologia per fatti concludenti.
Ma qualcosa, molte cose mettono quell’album al centro del
prisma le cui facce si chiamano Peri, Caccini, Monteverdi, Carissimi,
Cara, Tromboncino, Cavalli, Frescobaldi, Scarlatti, Porpora, Mozart,
Bellini: sono il rapporto con il violino, la simbiosi con lo
strumento Doppelgänger della voce umana, il viaggio nel tempo e nel
luogo di una musica destinata a subire una migrazione di anima e corpo,
verso nord, che non l’avrebbe lasciata uguale a se stessa.
GEOGRAFIE
Il lavoro di Nella Anfuso sul proprio strumento Voce, e
sulla vocalità italiana in generale, parte inderogabilmente dalle
radici. Non ci sono salti o buchi, e questo è il carattere forte,
musicologico di un percorso lungo trent’anni, trentaquattro album audio
e nove video, tutti sostenuti e corredati dai saggi preziosi,
decisivi di Annibale Gianuario.
Alle origini stanno alcuni pezzi pregiati che
stupiscono oggi non meno del momento in cui apparvero, e le origini
sono quegli “ambienti” di arte e cultura, strette in vincoli
assoluti, che costruirono la più alta estetica “di sintesi”
che l’uomo abbia mai creato per sé, in aderenza piena all’umanesimo di
ceppo platonico. “Quant’è bella giovinezza” e “Il Canto alla
Corte di Isabella d’Este” ci riportano indietro nel tempo e al cuore
del Rinascimento. La vocalità che segue come un’ombra il dettato del
verso poetico letteralmente ricostruisce ai nostri occhi, attraverso
l’orecchio, le sale a libera eco delle corti dei Medici a Firenze e
degli Este a Mantova; ridà corpo, volti e figure alle riunioni in cui
chi usava la parola, chi il canto, il liuto, la viola, la matita, il
pennello, si ritrovavano nello stesso cerchio magico, sul medesimo
tappeto volante. Erano i luoghi in cui nascevano insieme le cose
dell’arte che la storia, un secolo e mezzo più tardi, avrebbe diviso.

Anche cronologicamente siamo alle origini di tutto.
Rivediamo Lorenzo il Magnifico che canta con Marsilio Ficino e Baccio
Ugolini, primo interprete dell’Orfeo di Poliziano. Che in una lettera
del 1488 ci descrive quel che nel canto di Nella Anfuso, grazie all’éra
della riproducibilità dell’arte, possiamo ascoltare: “..Fu la voce
non del tutto di uno che leggesse e non del tutto di uno che cantasse,
ma avresti potuto sentirvi e l’uno e l’altro e pure distinguere l’uno
dall’altro; era tuttavia o piana o modulata, mutando come lo richiedesse
il passaggio, ora variata ed ora sostenuta, ora esaltata ed ora
moderata, ora sedata ed ora veemente, ora rallentata ed ora accelerata,
sempre precisa, sempre chiara e gradevole…”.
Come osservava senza possibilità di replica il professor
Gianuario: “questo documento anticipa di oltre un secolo la
sprezzatura cacciniana e il ‘si canta senza battuta’ di
Monteverdi monodico e polifonico”.
È lo stesso spirito che si ascolta e si respira nel
“Canto alla Corte di Isabella d’Este”, album del 1988, che di un
altro aspetto della cultura e della musica rinascimentale dà
dimostrazione per fatti: la velocità migratoria delle idee e delle
pratiche. Se il Poliziano, da Roma, testimonia che nella città dei Papi
si canta come in quella dei Medici, Isabella d’Este, che nasce nella
Ferrara di Ercole nel 1474 e che nel ’90 si sposta nella Mantova del
marito Francesco II, circondandosi di artisti come Giulio Romano e, pur
per poco, di Raffaello e Leonardo da Vinci (che la ritrasse), di poeti
come Ludovico Ariosto, Pietro Bembo e Baldassarre Castiglione, di
musicisti come Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Michele Pesenti,
Ludovico da Milano, e di cantori che restano nella storia per brevi
citazioni della loro arte, Isabella d’Este, dunque, dimostra quale forza
magnetica, quale coerenza, quale rocciosità vi sia nelle basi estetiche
del canto espressivo italiano al suo splendore.
Un altro luogo magico che Nella Anfuso ha riportato alla
luce nei suoi aspetti più autentici è la Roma della Cantata
Barocca: cinque esempi, due di Carissimi, uno ciascuno per Marco
Marazzoli, Francesco Tenaglia e, il più straordinario, di Luigi Rossi -
il “Lamento della Regina di Svetia”, Eleonora, in morte del re
Gustavo Adolfo - bastavano a dar conto di quel che, in musica, potesse
essere il corrispondente reale di una città che stava dandosi
un’impronta architettonica ispirata a una fantasia prodigiosa, ma con
ben salde radici negli equilibri, soprattutto spaziali, dell’antichità.
(Equilibri spinti fin nei colori: le romane sfumature dell’ocra, un
giorno, nei primi anni del Novecento, Igor Stravinskij le avrebbe
riconosciute familiari, perché la sua Pietroburgo, follia grandiosa del
più “barocco” fra gli zar, Pietro, l’aveva voluta così italiana da
chiamare non soltanto gli architetti a progettarla, i Quarenghi e i
Rastrelli, ma perfino gli artigiani, che le avevano impresso anche i
cromatismi degli intonaci, uguali a quelli della città dei papi. “Mi
chiedo se sulla mia musica - scriveva Stravinskij - non abbia avuto una
qualche influenza l’essere nato in una città ‘italiana’ ”. E
pensiamo istintivamente a Pulcinella, alla svolta neoclassica).
Nell’album “La Cantata Romana, ossia il vero Barocco”,
c’è la testimonianza di quanto il volo delle fioriture che si andava
affermando come naturale necessità dell’estetica nuova, nel segno del
grande e dell’imprevedibile, non avesse levato le àncore dai princìpi
fondamentali del canto espressivo come gli altri luoghi della tradizione
- Firenze, Ferrara, Mantova - li avevano scolpiti nella storia.
Nella Anfuso ridava voce alla schiera di
cantatrici, sacre (monache) e profane, che cominciavano a sostituire
anche in chiesa i falsettisti a voce fissa (e falsa, come ostenta il
nome) e i pueri cantores; alle Vittoria, Adriana, Leonora che il
Della Valle descriveva finalmente padrone “… del piano e del
forte; del crescere la voce a poco a poco, dello smorzarla con grazia,
dell’espressione degli affetti, del secondar con giudizio le parole e i
loro sensi; del rallegrar la voce o immalinconirla; del farla pietosa o
ardita, quando bisogni”.
Insomma, il virtuosismo con ben fissa la stella polare
dell’Espressione, nel tempo che i libri di scuola riducono ancora
nell’angolo infantile dell’eccesso e dello stupore. Dimostrazione che la
musica, se restituita da noi nei suoi valori autentici, può darci
strumenti di interpretazione concreti anche per le arti “collegate”.
MAESTRI
Il cuore della ricerca di Nella Anfuso, in cui l’apporto
musicologico si è focalizzato e poi irradiato in ogni direzione, ha però
nomi e cognomi precisi. E a baricentro dei registri di petto e di testa,
in senso materiale e figurato, si pongono gli album dedicati al Divino
Claudio: “Parlar Cantando I” e “Parlar Cantando II”,
“Mottetti”, “Scherzi e Arie”, “Musica Sacra”,
“Madrigali scelti”. Sei: il maggior numero nel corpo dei
trentaquattro.
Monteverdi è, e non potrebbe essere altrimenti, il perno
su cui tutto l’opus Anfuso poggia e si snoda. Sarebbe
incomprensibile e inconcepibile tutto il lavoro sullo strumento voce e
sul canto come concentrazione di estetica, tecnica, filosofia e
pensiero, senza l’approfondimento di quel momento della storia della
musica in cui un compositore concepì la parola, il suo significato, il
suo stesso suono, come genesi autosufficiente, autoreferente e
autorigenerante del far musica.
In quei sei album - e nel video “Claudio Monteverdi
- La Poiesis” - il viaggio al centro della Voce raggiunge la
meta. Non abbiamo riscontri in altri ambienti dell’Europa
musicale, né mondiale, di una ricerca così approfondita
e consapevole delle coordinate storiche della Seconda Pratica
monteverdiana; non abbiamo confronti, se non disperatamente
mediocri e/o fuorvianti, di una vocalità che sia capace di
individuare e illuminare con tanta sicurezza il punto di contatto tra
parola letteraria e parola musicale.
Il Monteverdi di Nella Anfuso resta,
pericolosamente per tutti i cantanti stranieri e ancora troppi italiani,
il riferimento.

Come paggi a latere stanno Jacopo Peri (“Madrigali”,
“Arie e Lamenti I e II”) e Giulio Caccini (“Madrigali scelti”):
la loro ricerca - far sì che la musica, dunque la voce, “possa
penetrare nell’altrui intelletto, e fare quei mirabili effetti, che
ammirano gli Scrittori” (Caccini) -, coincide con quella di
Monteverdi. I mezzi per la “rappresentazione degli affetti” sono
gli stessi, l’arte della variazione poggia sui medesimi capisaldi: l’eguaglianza
dei registri, la naturalezza dell’emissione, “l’aumentare
e il diminuire la voce” in sintonia con le esigenze espressive, la
padronanza tecnica assoluta nei passaggi e nei trilli
a note ben staccate (spiccate). Tutti elementi di una vocalità
naturale che allunga la vita allo strumento e - Nella Anfuso
dimostra - può e deve applicarsi a qualunque repertorio, nel
segno di una continuità del canto che solo accidenti della storia hanno
spezzato.
Ecco dunque le dimostrazioni pratiche nel “Canto
figurato da Mozart a Bellini” e - vertice - nella
ricostruzione dell’arte di colui che resta nella storia del canto
come il più grande prodigio della natura innaturale: Farinello.
LO
SCISMA
Riprendiamo per un attimo il filo Vivaldi. Perché
considerare cruciale quel momento nell’opus Anfuso?
Si sa: contemporanei suoi e nostri, anche di rispetto,
hanno rafforzato l’opinione che il Prete Rosso trattasse l’ugola
“come il manico di un violino”. Nelle interpretazioni di Nella
Anfuso, di questo snaturare la carne come fosse legno non c’è traccia.
Ma sappiamo bene che se la voce ha in uno strumento il suo replicante,
questi è proprio quel che gli Stradivari, i Guarneri e gli Amati hanno
reso miracolosamente grande quanto emblematico della musica stessa: sua
icona fin nel disegno. Attorno al violino ancor oggi aleggiano misteri
in qualche modo consanguinei ai segreti del vero canto. Più di ogni
fiato, è il violino lo strumento che prolunga il corpo, le sue
vibrazioni più intime, i suoi “affetti”. Poteva un violinista
come Vivaldi pretendere dalla voce qualcosa di innaturale?
Nella Anfuso ha dimostrato di no.
Ma è anche vero che proprio dal virtuosismo e dalla
grandezza del violino di Vivaldi - che il destino fece morire in
circostanze non chiare a Vienna - prende le mosse una migrazione verso
Nord, un processo di lenta consegna delle chiavi della musica pura
dall’Italia ad altri Paesi. Il tempo della Sinfonia stava per nascere, e
le capitali non sarebbero state più la Roma dei Corelli e la Venezia dei
Vivaldi, maestri del Concerto, forma perfetta del linguaggio
strumentale come poche altre.
COSMO
Vent’anni fa nacque un movimento che tentò di imporre, o
meglio di reintrodurre, il La a 432 Herz, fondando le sue buone ragioni
anche su una lettera ben nota di Giuseppe Verdi, della cui conoscenza
dello strumento voce sarebbe curioso dubitare: “…fin da quando
venne adottato in Francia il diapason normale - scriveva Verdi nel
1888 alla commissione italiana che ne studiava l’introduzione per legge
- io consigliai venisse seguito l’esempio anche da noi; e domandai
formalmente alle orchestre di diverse città d’Italia, fra le altre a
quella della Scala, di abbassare il corista uniformandosi al normale
francese…Sarebbe grave, gravissimo errore adottare, come viene da Roma
proposto, un diapason di 450!!! Io sono pure d’opinione…che
l’abbassamento del corista non toglie nulla alla sonorità e al brio
dell’esecuzione, ma dà al contrario qualche cosa di più nobile, di più
pieno e maestoso che non potrebbero dare gli strilli di un corista
troppo acuto. Per parte mia vorrei che un solo corista venisse adottato
in tutto il mondo musicale. La lingua musicale è universale: perché
dunque la nota che ha nome La a Parigi o a Milano dovrebbe diventare un
Si bemolle a Roma?”. E quali effetti avrebbe, ha avuto e ancora ha
sulle voci?
Il La a 432 vibrazioni al secondo corrisponde a un Do
centrale di 256 Herz. Una corretta, leonardesca, kepleriana,
rinascimentale impostazione scientifica del problema acustico connesso a
ciò di cui parliamo, ha dimostrato che tale numero - il 256 -, rivesta
perfino un valore astronomico unico all’interno del sistema solare.
Il periodo di un ciclo del Do a 256 (1/256 di secondo) si
può ricavare dividendo il periodo di rotazione della Terra per 24 (2 x 3
x 4). Ottenuta l’ora, si divide quest’ultima per 60 (2 x 4 x 5)
ottenendo un minuto, e dividendo ancora per 60 si ottiene un secondo.
Dividendo il secondo per 256 (2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2) si verifica
come la rotazione della Terra corrisponda a un Sol di 16 ottave più
profondo esattamente del Do = 256, che viene così ad assumere un
significato concreto, verificabile all’interno dell’armonia
dell’universo. E il diapason “universale” coincide con quello naturale
della voce, le si accorda pienamente, la fa vivere con pienezza.
In realtà il problema del “corista” è variabile per
natura e per storia. Esistono diverse “quote” nell’accordatura degli
strumenti, anche sopra il La a 432, su cui la voce riesce a sistemarsi
con equilibrio di armonici. E si conoscono, anche in periodi d’oro della
storia, molte difformità di accordatura fra le capitali e le province
della musica, in Italia come in Europa.
Basta ricordare en passant che la proposta del La
a 432 fu osteggiata e fatta naufragare dalle commissioni di Berlino e di
Vienna, capitali della musica sinfonica, per capire dove si erano
spostati i centri di potere, e lontano da quale strumento.
L’opus Anfuso, come piace continuarlo a chiamare,
mostra proprio sotto questa luce il suo incommensurabile valore:
è un grande monumento ai maestri, ai luoghi e al tempo in cui al
centro della musica c’era la Voce. Ovvero l’Uomo.
CARLO MARIA CELLA
Nato a Milano nel 1949. Critico musicale del
Giorno dal 1984. |