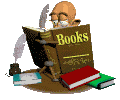Viaggio in Bretagna Quando arrivammo a Le Val Andrée il sole aveva appena iniziato a tramontare e, ormai basso all’orizzonte, rendeva sgargianti i colori delle barche; il mare era così verde che sembrava un blocco di giada, impreziosito dai riflessi dorati del tramonto. Le Val Andrée è un piccolo villaggio di pescatori non molto lontano da Saint Malo, in Bretagna; mi trovavo lì per lavoro. È un mestiere particolare, il mio: sono un killer, o meglio, un sicario (preferisco questa parola, ha un che di romantico che la corrispondente inglese non ha); a dire il vero il mio lavoro ha ben poco di romantico; non credo di sapere con esattezza perché faccio quello che faccio: non mi piace uccidere, forse è per i soldi – sarei bugiardo se lo negassi, anche perché ne riesco a mettere da parte parecchi- forse è per la sensazione di potere che provo mentre decido come agire, mentre decido come, dove e quando il bersaglio dovrà morire; forse è il brivido che provo durante il pericolo, l’unico brivido che ormai mi ricorda che sono vivo, o forse semplicemente perché uccidere è l’unica cosa che io sappia fare, o, se non altro, che sappia fare veramente bene.. Generalmente lavoro da solo ma in certe occasioni, i capi – perché anche un sicario ha dei capi - pensano sia meglio che io venga affiancato da qualcuno. Questa era una di quelle occasioni. Mi è sempre stata affiancata la stessa persona: un ottuso bestione dalla testa rasata di cui l’agenzia si fida ciecamente, molto di più di quanto si fidino di me (e credo che a volte me lo mandino dietro non per aiutarmi ma per controllarmi). È il classico prepotente, conscio della sua forza che usa senza misura con i più deboli. E’ stupido, a volte se ne rende conto e allora diventa ancora più cattivo. Lo odio. Questa volta dovevamo occuparci di un sindacalista francese, un ecologista, che con il suo continuo schiamazzare aveva pestato i piedi ad una grande industria alimentare. Una settimana fa scoprirono che aveva messo le mani su di un rapporto relativo alla composizione di certi mangimi. Il sindacalista si era messo in contatto con la redazione di un giornale, ignorando però che, per ironia della sorte, tale giornale era di proprietà della stessa multinazionale che stava per denunciare. Tale situazione arrivò in breve tempo alle orecchie dei vertici del gruppo. Dopo una riunione d’emergenza contattarono i miei capi e loro contattarono me. Partimmo subito per la Francia. All’aeroporto De Gaulle noleggiammo un’auto e, dopo aver recuperato le armi che ci servivano, ci dirigemmo verso il nord. Lasciammo l’auto all’ingresso del villaggio e seguimmo la banchina del porto per la sua lunghezza in direzione del mare. Non era, quello, un porto vero e proprio, era più che altro un canale lungo e stretto che dava ricovero alle barche dei pescatori e permetteva di allevare qualche ostrica. C’erano decine di piccole imbarcazioni in secca con le fiancate appoggiate al molo a causa della bassa marea e un forte vento rabbioso appiccicava i vestiti al corpo. Camminavamo come turisti, senza una meta precisa, bighellonando nei negozietti e curiosando nei cantieri navali. Mi sembrava di rivivere le passeggiate al tramonto di quando ero ragazzo e camminavo con mio padre sugli scogli, guardando i pescatori che recuperavano le lenze e tornavano a casa per la cena. Io trotterellavo dietro a lui sperando che mi raccontasse qualche storia o che mi mostrasse qualche cosa di interessante, qualunque cosa, anche un semplice cespuglio d’origano, che mostratomi da lui mi sarebbe parso affascinante come una nave all’orizzonte. Bevevo ogni cosa mi dicesse e mi sentivo fiero che lui dividesse qualche cosa con me, un’esperienza o un racconto. Credo che i ricordi più remoti che ho siano l’unica cosa che mi permetta di andare avanti, di conservare una parvenza di umanità in un’anima ormai già morta. Per questo motivo mi affido così sovente al ricordo, alla memoria, l’unico spazio in cui possa rinchiudermi per non impazzire.
- E’ ora di cena – disse il mio bestione richiamandomi al presente – Lui adesso non verrà, possiamo fermarci a mangiare. Scegliemmo un piccolo ristorante sul molo, dove ordinammo un vassoio di ostriche. Le ostriche erano freschissime e lasciavano in bocca un forte sapore salmastro che resisteva anche dopo numerose sorsate di birra. Il brusio proveniente dagli altri tavoli dava una piacevole sensazione di calma e le persone che passeggiavano tranquillamente sul marciapiede di fronte a noi mi facevano sembrare ancora più irreale la situazione: facevo fatica a ricordarmi che non ero lì in vacanza ma per uccidere.
Nel locale lavoravano due ragazze giovani e molto belle, come sembra essere la norma per le ragazze bretoni. - Carine le cameriere – e ammiccai al mio socio. Lui grugnì qualcosa con la bocca piena, sbrodolandosi il mento e scoppiò poi a ridere rumorosamente. Voltai la faccia infastidito da quell’ebete e incrociai lo sguardo di una delle ragazze che lo fissava disgustata. Pagammo e ci alzammo, dopodiché cercammo un bar per attendere il buio. Era un locale per turisti, con la sabbia sul pavimento e reti da pesca alle pareti. Due ragazzi suonavano canzoni francesi, uno ad un piano malandato e l’altro con una vecchia chitarra. Di fronte a loro era seduta una ragazza sui trent’anni, in jeans e maglietta, ubriaca. Se ne stava piegata in avanti, mezzo distesa sul tavolo con la testa appoggiata sulle braccia e pareva dormisse se non che, di tanto in tanto, si alzava di scatto, faceva un paio di giri su se stessa, improvvisando dei passi di danza e ripiombava a sedere. Non capivo se era solo ubriaca o fosse anche un po’ pazza…in ogni caso mi fece una gran pena. Ad un tratto prese il cappello che uno dei musicisti aveva appoggiato al tavolo e iniziò a girare per il bar cercando di convincere i clienti a lasciare qualche mancia per i ragazzi. Non aveva racimolato neanche un soldo quando decise di dirigersi verso di noi; giuro che stavo per mettere la mano al portafogli, impietosito non tanto per i musicisti ma per la ragazza che non veniva ascoltata da nessuno, ma il padrone del locale l’afferrò per un braccio e l’accompagnò all’uscita. Ci rimasi male e il mio “socio” se ne accorse, perché mi sorrise con quel suo sorriso storto e cattivo scuotendo il capo. Stavo per chiedergli se c’era qualcosa che non gli andasse bene quando il mio cellulare suonò. Era il segnale che attendevamo. Il nostro uomo aveva lasciato il lavoro e stava dirigendosi verso casa. Finimmo il nostro sidro con calma, sapendo che avevamo ancora mezz’ora di tempo, e uscimmo tranquillamente nel fresco della sera. Ci avviammo verso l’indirizzo che ci era stato dato. La casa era talmente bella che sembrava finta, piccola e linda come nelle fiabe con le finestre che brillavano allegre nel buio e le pareti bianche che riflettevano la luce della luna. Questo è il momento più difficile del nostro lavoro. Quello dell’attesa. Quando ti assillano i dubbi e la paura, quando ti domandi se vale la pena di fare quello che stai per fare. E’ la prima volta che attendi in cui capisci se diverrai qualcuno. Sentimmo i passi nel buio e per prima cosa vedemmo l’ombra dell’uomo proiettata sul muro diventare sempre più grossa. Lo seguiva una donna. Camminava un passo dietro a lui con l’aria molto imbronciata. Intuii che fosse la sua ragazza e che per qualche motivo i due avevano appena litigato. La cosa mi colpì, sia perché lei non era prevista, (evidentemente chi ci aveva mandato il segnale non poteva sapere che i due si sarebbero incontrati lungo la strada) sia, soprattutto, perché la sua presenza, la presenza di qualcuno legato alla persona che avrei dovuto uccidere, mi fece capire per la prima volta quello che faccio per vivere. Quando uccido non prendo solo la vita della vittima ma trascino con me parte della vita di chi gli sta intorno. Probabilmente l’unica cosa che occupava la loro mente fino a cinque minuti prima era il motivo per cui avevano litigato. Forse la ragazza gli aveva anche detto che lo avrebbe lasciato, sapendo comunque che non l’avrebbe mai fatto, pensando che avrebbe avuto tutto il tempo, quella notte, per farlo soffrire un po’ e poi perdonarlo; pensava che avrebbe avuto tutto il tempo per rimangiarsi le cose che gli aveva detto con rabbia, ma che non pensava veramente.. Invece questo tempo non ce l’avrebbe avuto. Ciò che gli aveva appena detto non sarebbe mai stato rimangiato e la situazione in cui essi vivevano in quel momento si sarebbe protratta per l’eternità. Mi resi conto dell’assurdità di tutto questo, la stessa assurdità della vita, la stessa assurdità che non ci fa credere possibile che la ragazza che abbiamo appena salutato all’uscita del bar si sia schiantata in macchina cento metri dopo e che noi non l’avremmo mai più rivista.
Fu in quell’istante che capii che, in un modo o nell’altro, la mia carriera era finita. Una voce dentro me gridò basta, e le mani si strinsero sull’impugnatura della pistola che tenevo in tasca. Fissavo ansimando la nuca rasata del mio bestione che, nel frattempo, aveva estratto la sua arma e, come al rallentatore, mi precedeva silenzioso e calmo verso i due giovani. La sua nuca, mi ricordo la sua nuca, pallida nel buio, mi ricordo i ragazzi che ci guardano stupiti dal nostro improvviso apparire ma senza nessun sospetto, mi ricordo che noi eravamo i cattivi e loro no, mi ricordo come alzai lentamente il braccio prendendo la mira verso la testa del mio compagno tanto stupido e tanto odiato.
Ci furono due colpi soli, secchi, le cui uniche testimonianze furono due lampi che rimbalzarono per il vicolo, il fruscio dei silenziatori e il tintinnio dei bossoli espulsi sul selciato. E’ incredibile la quantità di sangue contenuta nel corpo umano, mi stupisco ogni volta di quanta ne possa uscire da una ferita e con quale violenza, e anche questa volta non potei fare a meno di fermarmi un istante a contemplare il rigagnolo vermiglio che correva sul selciato, luccicando malignamente, fino a perdersi nell’ombra di una casa. - Questa volta il bonus spetta a me- mi disse il gigante – sono stato io a fare il lavoro. Infatti il lavoro l’aveva fatto lui, si era avvicinato tranquillamente verso gli obiettivi e aveva sparato un colpo per ognuno di loro. Lui non si era accorto di niente, né della mia confusione né del fatto che stessi per sparargli. Lui non si era accorto di niente, mentre io non seppi fare niente. Stavo per salvare due vite prendendo quella di un assassino ma non ci sono riuscito, oppure non ho voluto… non lo so. Una cosa sola sapevo: mi sarei chiamato fuori, avrei chiuso con quell’ambiente. Il problema era come: il mio lavoro non è un genere di lavoro che si può concludere con una lettera di dimissioni. Decisi di sparire, e in fretta, perché ero sicuro che il prossimo obiettivo del mio socio sarei stato io. Rimasi a contemplare i due corpi accasciati sulla strada fino a quando lui non mi scosse
- Che diavolo hai? – mi disse – muoviti, leviamoci di torno! Alla prima svolta ci sbarazzammo delle pistole e, senza fretta, ci dirigemmo verso l’automobile. - E’ un peccato non poter più tornare in Bretagna, hanno delle ostriche deliziose.- mi disse l’idiota accendendosi una sigaretta.
L’alta marea era tornata e le barche galleggiavano pigre sullo sciabordio dell’acqua che lambiva il molo.
|